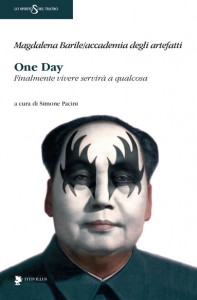Epica, Etica e Pop – manovre di uscita dalla post-modernità tra letteratura e teatro.
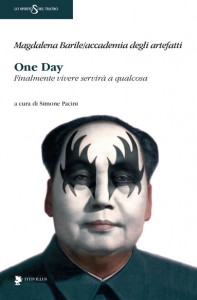
A fine novembre, al Kollatino di Roma, in occasione dell’ultimo appuntamento di Novo Critico, l’Accademia degli Artefatti ha presentato in lettura alcune scene tratte da «One Day», lo spettacolo di 24 ore che doveva debuttare nel 2008 al festival Romaeuropa ma che, a causa di problemi produttivi, non ha mai visto la luce. Nonostante non sia stato portato a termine, per il regista Fabrizio Arcuri «One Day» resta il miglior pezzo di teatro realizzato dalla sua compagnia, perché era “nato per testimoniare l’assoluta inadeguatezza del sistema” e coerentemente è stato “abortito per mano di questa inadeguatezza”. In effetti «One Day» aleggia come un fantasma sulla attuale situazione di dismissione di spazi e finanziamenti che sta minando il sistema teatrale italiano, perché ne è stato forse il primo concreto campanello d’allarme, e gode per tanto oggi di una luce quasi “mitica”.
È inutile cimentarsi in una recensione di uno spettacolo mai andato in scena, di cui sono state presentate solo alcune parti e per di più in lettura. Sarebbe una restituzione necessariamente parziale, visto che «One Day» è un’opera-mondo estremamente complessa, che avrebbe dovuto ospitare al suo interno altri spettacoli, e che proponeva diversi piani di realtà e filoni di storia in un intreccio elaboratissimo: dal rapimento di un bambino rumeno alla parabola del pupazzo Dolly Bell che raffigura un coniglio ceceno (ma Dolly Bell è anche tante altre cose…), dalle performance live dei Kiss – il gruppo preferito del bambino, ma anche l’icona esemplare della riproducibilità pop, qui accostata addirittura all’opera di Pechino – alle avventure del pornoattore Tito, passando per le maglie noir di un affare di traffico d’organi. E questo è solo un assaggio della drammaturgia elaborata da Magdalena Barile a partire dalle idee di Fabrizio Arcuri e dalle improvvisazioni dei suoi attori – oggi raccolta in un libro uscito di recente per Titivillus.
Tuttavia l’operazione di «One Day» può fornire uno spunto di riflessione interessante per leggere una tendenza che si sta delineando nel teatro internazionale. «One Day», come «Spara/Trova il tesoro/Ripeti» – i diciassette pezzi scritti dal drammaturgo inglese Mark Ravenhill e messi in scena sempre da Arcuri – o come la teatronovela di Rafael Spregelburd «Bizarra», la cui versione italiana realizzata da Manuela Cherubini è attualmente in scena all’Angelo Mai di Roma, sono tutti esempi di utilizzo di una forma insolita per il teatro: il ciclo
1. Insolita perché la perenne crisi in cui versa il teatro ci ha abituati a spettacoli sempre più piccoli, con pochi attori quando non uno solo, con scenografie ridotte o inesistenti, insomma un teatro “tascabile” da poter spostare facilmente e a poco prezzo (con l’unica deroga del teatro che lavora sulla visione e intercetta circuiti che si intersecano con l’arte visiva).
Il ciclo non è semplicemente uno spettacolo più lungo – altrimenti dovremmo includere in questo ragionamento anche operazioni come quella di Peter Stein con «I demoni» – o una forma che straborda dai confini abituali del teatro. Certo, sia in «One Day» che in «Bizarra», ad esempio, la scelta di realizzare uno spettacolo fuori scala, fuori misura, è anche una sfida diretta a un sistema teatrale (nel caso italiano) e a una congiuntura economica (nel caso argentino) che sembrano voler comprimere il teatro in modo irrimediabile. Ma la forma del ciclo ha anche delle implicazioni drammaturgiche particolarmente interessanti, che danno il segno di un tentativo di smarcarsi dall’estetica del frammento che ha caratterizzato la stagione del post-modernismo senza però tornare pedissequamente a una messa in scena di tipo classico.
Il ciclo ha a che vedere con l’epica, ne è anzi la sua forma classica, e l’epica è certamente presente in tutte queste opere, che nella loro complessità presentano diversi tratti tipici del racconto epico. A sorpresa, nell’epoca della comunicazione rapida e di superficie, sembra sia proprio il racconto epico, con la sua stratificazione e il suo tempo di fruizione decisamente superiore allo standard abituale, a suggerire una possibile via di uscita dal post-moderno, dalla sua frammentazione, dalla sua negazione del racconto in favore di un’opera aperta dalle letture molteplici e tutte egualmente valide. D’altronde se uno dei pilastri delle teorie sulla post-modernità era proprio la fine della storia – e il concetto elaborato da Francis Fukuyama altro non era se non l’attestazione dell’impossibilità di riprendere un racconto epico della storia contemporanea dopo il crollo del comunismo e la messa in discussione dell’ideale di matrice marxista del progresso come motore della storia –, per converso è proprio con l’epica che la storia inizia. Perché è l’epica l’unico genere in grado di partorire i miti fondativi su cui si ergono le grandi narrazioni.
Qualcosa del genere l’ha intuito negli stessi anni la letteratura, che proprio nell’ultimo decennio ha cercato di uscire dall’empasse in cui si era cacciata tempo prima, messa alle corde da un minimalismo più di idee che stilistico. Nel nostro paese si possono ricordare operazioni come i «Canti del Caos» di Antonio Moresco, mentre la New Italian Epic – termine proposto nel 2008 da Wu Ming 1 per circoscrivere un’insieme di autori e opere letterarie uscite a nell’arco che va dalla seconda metà degli anni Novanta al primo decennio del nuovo secolo
2 – è oggi una categoria che anima con forza il dibattito letterario. Anche se questa definizione prende in considerazione romanzi di ambientazione storica o metastorica, è possibile proporre un parallelismo di fondo, magari spurio, con quanto avviene nel teatro dove invece l’ambientazione è rigorosamente legata al presente e addirittura all’attualità. In entrambi i casi, comunque sia, si cerca nell’epica il meccanismo in grado di riattivare gli stanchi meccanismi della narrazione, la scintilla in grado di “avvincere” il lettore/spettatore, come si dice.
Facciamo subito due precisazioni. La prima è che l’epica, nonostante sia una parola che affascina, una parola “euforica” che evoca vastità di orizzonti, grandezza di scrittura e d’impresa – per usare una definizione della critica letteraria Carla Benedetti
3 – non è necessariamente intrisa di etica. Ai suoi meccanismi sono ricorsi anche – e ben prima di teatro e letteratura – gli sceneggiatori televisivi statunitensi, tanto che le loro serie tv sono il principale prodotto di intrattenimento di questi anni. Ovviamente con ciò non voglio affermare che le serie tv siano necessariamente portatrici di contenuti non etici, ci mancherebbe; ma è giusto sottolineare che la capacità di rifarsi all’epica e ai suoi meccanismi appartiene anche ai prodotti commerciali di intrattenimento (per altro il più delle volte sono prodotti di ottima fattura e che si avvalgono di sceneggiatori di alto livello). D’altronde stiamo parlando di una “forma”, per quanto complessa essa sia e per quanto in campo estetico la forma sia anche portatrice di sostanza; e le forme hanno un valore limitato nel tempo e nell’utilizzo che se ne fa: se servono a scardinare convenzioni e illuminare percorsi di ragionamento sul mondo che ci circonda – a spostare continuamente l’oggetto, dice Fabrizio Arcuri
4, affinché forma e oggetto non sclerotizzino il loro rapporto svuotandolo di senso – hanno un valore contiguo a quel valore sociale che riconosciamo all’arte piuttosto che all’intrattenimento. «A volte le rivoluzioni passano per l’invenzione di nuove forme», dice Rafael Spregelburd in un’intervista pubblicata da Lo Straniero
5. Ma, appunto, in questo caso il valore rivoluzionario sta tanto nella forma quanto nell’atto dell’inventare.
Seconda precisazione: la vera colpa della post-modernità, dal punto di vista delle forme estetiche che ha espresso, sta nel fatto che a causa della sua formulazione apocalittica queste si pretendono implicitamente come un orizzonte estetico definitivo e impossibile da superare (anche se allo stesso tempo inneggiano al perseguimento del “nuovo”, categoria mitizzata e spesso equivocata). Inoltre, se e quando queste forme estetiche vengono praticate in nome di una critica-denuncia della realtà coatta della post-modernità stessa, esse risultano spesso troppo contigue all’oggetto della propria critica, rendendo di fatto impossibile distinguere tra “adesione” e “denuncia” (per altro in perfetta coerenza con la post-modernità dove tutto e il contrario di tutto collassa nel buco nero di uno stesso orizzonte senza possibilità di futuri eventi: forse, da questo punto di vista, quella sulla post-modernità è l’unica teoria filosofica e sociologica ad essere contemporaneamente apocalittica e integrata). Insomma, come si fa a dire se siamo “contro” o “a favore”? Come possiamo sapere, dentro questo quadro, se l’arte ha talmente abbassato la sua voce da farla confluire in quel “raffinato silenzio” che è la confusione mediatica – secondo una felice espressione di Ascanio Celestini – o se invece sta gridando a gran voce? Non è dato saperlo, perché nel mare magnum della post-modernità non c’è più un fuori o un dentro, e porre simili questioni equivale a disquisire del sesso degli angeli…
Ovviamente non è vero che non sia possibile distinguere il grano dal loglio, né per altro il fatto di prendere posizione può essere ridotto a un atteggiamento da stadio basato sul pro e contro. Le sfumature esistono, e spesso è da esse che le contraddizioni emergono non come elemento di confusione, ma come forma di illuminazione. Per questo, accanto alle due precisazioni fatte nel paragrafo precedente, e conseguentemente ad esse, va notato che queste forme di epica – quelle teatrali come quelle letterarie – non hanno alcun problema a dialogare con un altro ingrediente cardine delle pastoie della post-modernità e della loro pretesa di confinare il reale in un eterno presente, un presente espanso immemore del passato e che non prevede il futuro: il Pop.
Il filosofo Maurizio Ferraris, in un recente articolo
6 apparso su La Repubblica, scrive che il post-moderno può essere sintetizzato in tre parole di undici lettere in tutto: Iper Pop Post. «l’Iper come valutazione positiva dell’eccesso e come rifiuto della misura, il Pop come miscela di alto e basso nel sistema dei media, e soprattutto il Post, l’idea di essere postumi, di venire dopo», scrive Ferraris.
Certamente il ricorso all’epica cerca di lasciarsi alle spalle il Post: la rivendicazione è portata avanti con forza da parte di questi artisti, tanto che Fabrizio Arcuri di questo ragionamento ne fa un fil rouge che attraversa esplicitamente la complessa stratificazione di «One Day»; mentre l’Institute of Germanic and Romance Studies dell’Università di Londra ha deciso di intitolare la pubblicazione degli atti di due conferenze sulla New Italian Epic in modo emblematico: “Overcoming Postmodernism”. Ma l’Iper e il Pop? Sono elementi costitutivi tanto della teatro-novela di Rafael Spregelburd o della maratona di «One Day», quanto di romanzi metastorici come «Q» di Luther Blissett (il precedente nome collettivo del gruppo di scrittori oggi noto come Wu Ming) o di scritture debordanti come «I canti del caos». Tutti questi oggetti artistici sono “eccessivi”, e tutti si immergono volentieri nell’oceano del Pop e ne fanno un elemento di fascinazione. Questo vuol dire che la loro voce si unisce al raffinato silenzio della confusione mediatica?
Impossibile dare una risposta univoca, in grado di fornire una qualche equazione di portata generale. Alla fin fine – ed è un bene! – sono sempre le opere a parlare per se stesse, e non le teorie. Però si può azzardare un’ipotesi di massima, e cioè che quando il ricorso all’Iper e al Pop è di matrice esclusivamente seduttiva, esso si situa sulla frequenza del rumore di fondo, del raffinato silenzio della confusione mediatica. Se invece tale ricorso costituisce sì una fascinazione, ma che ha il compito non di sedurre, bensì di aprire squarci di riflessione sul presente, allora esso si colloca in una frequenza diversa, dove le parole sono distinguibili, e i loro significati, anche se presentano sfaccettature molteplici, sono certamente lontani dall’essere ambigui.
In questo quadro mi sembra che, a prima vista, il teatro dei cicli e dell’epica contemporanea presenti qualche anticorpo in più rispetto a un fenomeno come la New Italan Epic. Nella letteratura il ricorso all’epica è sì un tentativo riuscito di recuperare un più ampio respiro a una narrativa che sembrava destinata ad avere il fiato corto; ma la narrazione mantiene un grado di finzionalità decisamente elevato, dove da questo punto di vista l’epica non è altro che il nuovo patto comunicativo tra chi scrive e chi legge, nient’altro che la “forma in voga”. Certo, poi questa forma può essere utile per tornare a mettere sul piatto della letteratura tematiche importanti e di più ampio respiro – ad esempio il “destino dei popoli”, secondo Wu Ming – ma è spesso anche un meccanismo strumentale che utilizza la forma in modo seduttivo, ed è quindi a forte rischio di retorica. Nelle arti che utilizzano la parola questo rischio si materializza di solito quando si è convinti, in modo più o meno manifesto, della superiorità del contenuto rispetto alla forma; mentre è il rapporto osmotico tra forma e sostanza a far scaturire l’alchimia necessaria affinché un oggetto d’arte parli davvero a chi lo fruisce. Non sto ovviamente affermando che l’intero corpus di romanzi citati da Wu Ming 1 nel suo saggio siano retorici, tutt’altro; ma che la loro finzionalità, il loro “crederci”, il loro ricorso all’epica per sentirsi epici, resti un limite – per altro un limite strutturale, visto che la narrativa è prevalentemente “fiction” – all’equazione “epica uguale recupero di un possibile discorso sul mondo”. Non dico che questa equazione non sia possibile, semplicemente che non è automatica. Perché manca un aspetto fondamentale per la letteratura, il terzo vertice del triangolo che poggia sull’asse forma-sostanza e che è forse l’elemento più importante: la lingua. È la lingua dello scrittore, il suo stile, a far sì che il patto comunicativo non resti mera seduzione ma produca uno spostamento dello sguardo del lettore sul mondo; e non a caso è proprio la lingua il grande rimosso della letteratura nell’epoca della post-modernità, è lo stile ad essere finito sul banco degli accusati per il fatto di costituire un ostacolo naturale alla comunicazione. Da questo punto di vista un esperimento straniante come «I canti del caos» di Moresco mi sembra un ricorso all’epica più complesso e riuscito.
Nel teatro la questione corre su un altro binario. Perché la riflessione sulla finzionalità è esplicita e irrinunciabile, è praticamente il rovello di ogni teatrante da quando esiste il teatro. E il tema della realtà e della finzione è intimamente connesso alla natura stessa del medium teatrale. Una buona fetta delle ultime generazioni teatrali italiane – a prescindere dal fatto che utilizzino o meno il genere epico – hanno declinato, in varie forme estetiche, un’urgenza comune: l’urgenza di scardinare in vari modi i meccanismi della comunicazione, di mostrare in scena il giocattolo rotto, spaccato, per poterne mostrare il funzionamento
7. Il capitale che il teatro si porta dietro, in questa riflessione, è la messa in discussione dell’idea di “rappresentazione” (in quanto elemento di finzione) che ha agitato le acque del dibattito teatrale praticamente durante tutto il Novecento. Il risultato – come a sottolineato Andrea Porcheddu durante l’incontro su «One Day» – è che oggi ad esempio è possibile assistere a spettacoli, in tutta Europa, che recuperano meccanismi di racconto e “messa in scena” ma che allo stesso tempo presentano quel fenomeno, mutuato dalla performing art, della “scomparsa del personaggio” (ovvero quando gli attori stanno sulla scena in quanto se stessi, e non perché stanno cercando di materializzare uno specifico personaggio). E questa coesistenza – al contrario di quanto avverrebbe in letteratura, dove si finirebbe subito nel campo nell’esperimento metaletterario – non dà all’opera un alone di metateatralità. Al contrario, recupera il patto comunicativo con lo spettatore sulla base del fatto che assieme a lui l’attore smonta la comunicazione abituale e i suoi meccanismi.
Tornando a quel teatro che sta facendo ricorso al ciclo e all’epica, esso pur immergendosi nelle acque agitate del Pop si porta in dote questa complessa e inesauribile riflessione dell’arte teatrale sulla finzionalità. L’essere obsoleto del medium teatrale, rispetto ad una post-modernità fatta di ipermedia digitali, fa sì che il posticcio della costruzione mediale della realtà sia in teatro sempre presente ed esplicito: gli attori (e dietro di loro i registi) devono costantemente interrogarsi su cosa dia loro il diritto di stare in scena, ovvero su cosa consenta loro di essere credibili di fronte a chi li sta a guardare. Non possono richiamarsi a un patto comunicativo che gioca sull’immedesimazione per così dire “immersiva” (come nel cinema, ad esempio, o nella letteratura), perché lo spettatore non è da solo davanti all’opera teatrale: ne è invece egli stesso una parte, perché senza lo spettatore il teatro non può fisicamente avvenire. Il grado zero del teatro è sempre e comunque l’incontro (anche fisico) tra esseri umani, tra spettatore e attore, e se c’è immedesimazione essa deve necessariamente passare per le dinamiche dell’incontro e del dialogo, del mettersi in relazione. Si tratta di un dato pratico che ha però un valore semantico preciso. Un aspetto del teatro che fa il palio a quanto afferma il regista Massimiliano Civica a proposito dell’autoralità in teatro: «Il regista e gli attori diventano un multinarratore che racconta al pubblico e si determina qualcosa che travalica la comprensione del singolo per dar luogo a un terzo. Chi l’autore di uno spettacolo teatrale? Secondo me nessuno: a teatro è sempre un terzo magico che parla ed è costituito dalla relazione
8». Se a questo ragionamento aggiungiamo il terzo vertice del triangolo che dà vita a uno spettacolo, e cioè il pubblico e la sua percezione, possiamo immaginare il teatro come qualcosa che si manifesta in un luogo ipotetico che è l’intersezione dove tutti questi soggetti si incontrano. Se vogliamo, da questo punto di vista, il teatro è un’arte decisamente più concettuale di tante altre arti.
La scelta del ricorso all’epica e al ciclo, allora, non essendo alla base del patto comunicativo del teatrante con lo spettatore, non rischia di invischiarsi in un meccanismo retorico del quale si tenta uno smontaggio costante – almeno in un certo tipo di teatro. L’epica si delinea quindi come il tentativo di invenzione di una linea narrativa complessa e stratifica, che tuttavia non giustifica di per sé l’operazione teatrale, semplicemente perché è “di grande respiro” o “ben fatta”, come una serie tv, ma perché inventa una forma nuova dal potenziale “rivoluzionario” nel senso espresso da Spregelburd.
Ciò vuol dire che nel teatro il ricorso all’epica è un fatto positivo e non lo è nella letteratura? Ovviamente non si può porre la questione in modo manicheo. Come ho già affermato le opere, siano esse di teatro che di letteratura, si possono giudicare solo per ciò che valgono e non per l’adesione ad una teoria piuttosto che ad un’altra – e per fortuna. Credo però che il ricorso all’epica non possa delinearsi come fatto virtuoso in sé – “etico” nell’accezione proposta prima – se non affronta il suo stretto legame con un alto dei vertici del triangolo della post-modernità: il Pop.
Che poi l’epica possa essere considerata il nostro pass per la fuga dalla post-modernità è tutto da verificare. Non può allontanarsi dall’Iper senza negare se stessa, e difficilmente rinuncerà al Pop perché è la carta che gioca per avvincere lo spettatore/lettore. Nella sua negazione del Post, tuttavia, disegna un orizzonte più vasto verso cui guadare che già permette di respirare meglio, di annusare un’aria meno viziata. E non è cosa da poco.
Graziano Graziani
10 dicembre 2010
8 Massimiliano Civica intervistato da Attilio Scarpellini, in «Sogno nella notte dell’estate» di William Shakespeare nella traduzione di Massimiliano Civica, a cura di Attilio Scarpellini, Editoria&Spettacolo 2010.